 |
| La Madonna nell'attesa del parto - Dipinto da Piero della Francesca (1457) |
O piccolo Bambino . . .
Mio unico tesoro !
Messa dell’aurora
Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,15-20)
Preghiera
Il mistero della tua incarnazione, Cristo Signore, è stato dispiegato all'umanità per mezzo dei tuoi santi angeli, a Zaccaria prima e a tua madre poi. Ma quando venne la pienezza dei tempi, gli angeli irruppero in un incantesimo di gloria a Dio e pace a noi - perché amati dal Padre - che ti ha dato di ritrovarti tra noi, non più alla sua destra, ma incarnato, uomo tra uomini.
E l’annunzio della tua nascita, Cristo Signore, è stato dato per primo agli ultimi, ai pastori, a coloro che Tu hai dichiarato saranno primi nel tuo Regno. Presi come siamo, dalla poetica del natale, non attendiamo a penetrare il mistero della tua incarnazione, il Vangelo del Regno, che Tu sei venuto ad annunziare, vedendo e vivendo tutto nella sua luce. Un malfattore inchiodato con te sulla croce entrerà per primo nel tuo Regno; i pastori, ritenuti ladri nel loro esercizio, hanno avuto il privilegio di avere per primi l’annuncio della tua incarnazione.
Gli ultimi sono stati i primi. La tua venuta nella carne è il dono del Padre a questa nostra umanità. Tu sei il dono per eccellenza. Noi da te prendiamo motivo per fare dei donativi a familiari, parenti amici e conoscenti e rendere a volte pagano questo mistero del Padre che ci fa dono del suo Figlio.
Facci Tu sentire lo spirito della tua incarnazione, del tuo natale, della tua venuta tra noi, per non incorrere nella banalità del consumismo. Fa’ che abbiamo a dare spessore e significato ad ogni dono, per l’amicizia, la stima, l’amore che condividiamo. Siano queste movenze materiali solo la gioia di partecipare simbolicamente al tuo grande dono, perché Tu, nato bambino, rendi tenero il nostro cuore e lo apri ad una espressione di grande umanità; sia quell'attenzione donativa, quell'amore verso il familiare, l’amico e quanti amiamo e vogliamo bene, a rendere il nostro amore umano, nel nostro piccolo, simile al tuo.
b) Il testo:
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell'albergo.
Bisogna anche dire però che non era facile per i suoi contemporanei riconoscere Gesù. Non è mai facile per nessuno, nemmeno oggi, riconoscerlo per quello che egli è veramente. Solo una rivelazione da parte di Dio ci può svelare il suo mistero (vedi ad esempio Gv 5, 37; 6, 45). Nel racconto della sua nascita, lo scopo dell’annuncio angelico è proprio quello di rivelarne il mistero.
Il nostro testo infatti è composto da tre parti. Nei vv. 1-7 abbiamo il fatto della nascita di Gesù in un contesto ben determinato. È la nascita di un bambino come tanti altri. I vv. 8-14 ci riferiscono l’annuncio da parte di un angelo e la visione di angeli che cantano. È la rivelazione da parte di Dio (vedi v. 15) che ci fa scoprire nel "segno" di "un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia" (v. 12) "il salvatore, Cristo Signore" (v. 11). Nell’ultima parte (vv. 15-20) troviamo varie reazioni di fronte alla rivelazione del mistero. Il segno che Dio offre, quando viene accolto umilmente, segna il punto di partenza del cammino di fede verso colui che si rivela.
Come decifrare il segno e accogliere Gesù
Il nostro testo ci presenta tre reazioni di fronte al mistero di Gesù.
Ci sono innanzitutto i pastori. Essi sono caratterizzati da vari verbi di attesa/ricerca e scoperta: "vegliavano di notte facendo la guardia" (v. 8); "andiamo a vedere..." (v. 15); "andarono senz’indugio e trovarono ..." (v. 16). I pastori furono aperti alla rivelazione del mistero. L’hanno accolta con semplicità credendovi (vedi vv. 15 e 20) e sono divenuti testimoni di ciò che fu loro rivelato (vedi v. 17). Ci sono poi "quelli che udirono" ciò che i pastori riferirono riguardo a Gesù (v. 16). Essi si stupiscono, incapaci di cogliere il vero significato dell’evento compiutosi tra di loro. Infine c’è la reazione di Maria. L’evangelista vuole contrastare la sua reazione con quella di "quelli che udirono". Infatti la introduce con la frase "da parte sua" (v. 19). Come loro, Maria non ha udito l’annuncio dell’angelo e non ha visto il coro angelico, ma ha soltanto udito la testimonianza dei pastori. Eppure lei la coglie. Certo, aveva avuto un annuncio angelico indirizzato proprio a lei all’inizio di questa vicenda (1, 26-38). L’angelo le aveva parlato del figlio che doveva nascere da lei come del Figlio dell’Altissimo che doveva regnare per sempre (vedi 1, 32 e 35). Ma gli ultimi fatti, la sua nascita in quelle circostanze, poteva mettere in dubbio la sua parola.
7. Orazione finale
Il mistero del Natale
« Colui che è, nasce.
Colui che è incomprensibile viene compreso.
Colui che arricchisce conosce la povertà.
Colui che è pienezza diviene vuoto.
Questo mistero mi riguarda:
io ebbi parte all'immagine di Dio
però non la conservai.
Egli allora prende parte alla mia carne
Per salvare l'immagine
E rendere immortale la carne. »
(San Gregorio Nazianzeno, Omelia 38)
Il Natale, come la Pasqua, rende presente il passaggio del cristiano dalla morte alla vita con Cristo. Si può affermare che l'oggetto della festività natalizia è il mistero della redenzione, che ha nella Pasqua il suo momento culminante. Nel Natale si tratta solo del punto di partenza dell'opera della salvezza ordinata al riscatto dell'uomo, riscatto che nell'evento del Natale è già contenuta in germe: Dio nella nascita di suo Figlio ha "dato mirabile principio alla nostra redenzione". La verità della redenzione dipende dalla verità dell'incarnazione. Il Natale è in qualche modo una Pasqua anticipata.
Le preghiere, le letture bibliche e gli altri testi dell'attuale liturgia natalizia del Messale Romano e della Liturgia delle Ore sottolineano questa dimensione salvifica del Natale.
La preghiera è tratta dal libro:
Pregare il Vangelo di P. Anastasio Francesco Filieri O Carm
« Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo,
quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine;
e molti secoli da quando, dopo il diluvio,
l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace;
ventuno secoli dopo che Abramo, nostro Padre nella fede,
migrò dalla terra di Ur dei Caldei;
tredici secoli dopo l'uscita del popolo d'Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè;
circa mille anni dopo l'unzione regale di Davide;
nella sessantacinquesima settimana secondo la profezia di Daniele;
all'epoca della centonovantaquattresima Olimpiade;
nell'anno settecentocinquantadue dalla fondazione di Roma;
nel quarantaduesimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto,
mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo,
Dio eterno e Figlio dell'eterno Padre,
volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta,
concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi,
nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria,
fatto uomo: Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne. »
 |
| VATICANO 1995, La Sacra Famiglia |
Il Natale è la solennità che celebra la nascita di Gesù Cristo. È chiamato anche Santo Natale, Natale di Gesù o Natività del Signore. La Chiesa Cattolica lo celebra, con la maggior parte delle altre Chiese cristiane, il 25 dicembre. La prima attestazione cristiana del Natale al 25 dicembre è del 204, ad opera di Ippolito di Roma. Il termine italiano Natale deriva dal latino [dies] Natalis, "[giorno] natalizio", ovviamente di Gesù.
Il Natale è una solennità di importanza pari a quella dell'Epifania, dell'Ascensione e della Pentecoste; è però di importanza inferiore alla Pasqua. Con i primi Vespri di Natale termina il Tempo d'Avvento e inizia il Tempo di Natale, che si protrae fino alla festa del Battesimo del Signore.
Il Natale è una solennità di importanza pari a quella dell'Epifania, dell'Ascensione e della Pentecoste; è però di importanza inferiore alla Pasqua. Con i primi Vespri di Natale termina il Tempo d'Avvento e inizia il Tempo di Natale, che si protrae fino alla festa del Battesimo del Signore.
Lectio Divina
La nascita di Gesù
Luca 2, 1-20
1. Orazione iniziale
Spirito di verità, inviatoci da Gesù per guidarci alla verità tutta intera, apri la nostra mente all'intelligenza delle Scritture. Tu che, scendendo su Maria di Nazaret, l’hai resa terra buona dove il Verbo di Dio ha potuto germinare, purifica i nostri cuori da tutto ciò che pone resistenza alla Parola. Fa’ che impariamo come lei ad ascoltare con cuore buono e perfetto la Parola che Dio ci rivolge nella vita e nella Scrittura, per custodirla e produrre frutto con la nostra perseveranza.
2. Lettura
a) Il contesto:
Il brano evangelico che ci viene proposto oggi fa parte del così detto vangelo dell’infanzia lucano che copre i primi due capitoli del terzo vangelo. Si tratta di un vangelo dell’infanzia. Quindi l’interesse primario dell’autore non è quello di informarci, di fornirci i dettagli storici della nascita di Gesù, bensì di annunciare la buona novella della nascita del Messia promesso. Il bambino Gesù è già visto come il Signore così come veniva proclamato nella predicazione apostolica. Come i primi due capitoli degli Atti degli Apostoli servono da transizione dal tempo di Gesù al tempo della Chiesa, così i primi due capitoli del vangelo di Luca servono da transizione dall'Antico al Nuovo Testamento. Le citazioni e allusioni all’Antico Testamento sono continue.
La nascita di Gesù
Luca 2, 1-20
1. Orazione iniziale
a) Il contesto:
 |
| SMOM 2004, L'Angelo e Zaccaria |
I personaggi, quali Zaccaria ed Elisabetta, Simeone e Anna, Giuseppe e soprattutto Maria, sono i rappresentanti della spiritualità dei poveri del Signore che caratterizza l’ultimo periodo dell’Antico Testamento.
Tutti quanti e particolarmente Maria si rallegrano per l’arrivo della salvezza nella quale avevano tanto sperato. Luca divide il suo vangelo dell’infanzia in sette scene: l’annunzio della nascita di Giovanni Battista (1, 5-25), l’annunzio della nascita di Gesù (1, 26-38), la visita di Maria a Elisabetta (1, 39-56), la nascita di Giovanni Battista (1, 57-80), la nascita di Gesù (2, 1-21), la presentazione di Gesù al tempio (2, 22-40), e Gesù tra i dottori nel tempio (2, 41-52). Molti studiosi sono del parere che Luca intendeva mettere in parallelo Gesù e il Battista per dimostrare la superiorità di Gesù su Giovanni, l’ultimo profeta. Con la nascita di Gesù iniziano i tempi nuovi verso i quali tutto l’Antico Testamento era orientato.
b) Il testo:
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell'albergo.
 |
| GERMANIA 1980 |
C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l’angelo disse loro:
«Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
pace in terra agli uomini che egli ama».
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».
Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
3. Momento di silenzio orante
perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita.
4. Alcune domande
3. Momento di silenzio orante
perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita.
4. Alcune domande
per aiutarci nella meditazione e nell'orazione.
a) C’è posto per Gesù nella mia vita?
b) Quali segni mi sta offrendo Dio della sua presenza?
c) Come reagisco di fronte ad essi?
d) Gesù è nato per portare gioia e pace. Quanto caratterizzano la mia vita questi doni?
e) Sono portatore di gioia e di pace per gli altri?
5. Una chiave di lettura
a) C’è posto per Gesù nella mia vita?
b) Quali segni mi sta offrendo Dio della sua presenza?
c) Come reagisco di fronte ad essi?
d) Gesù è nato per portare gioia e pace. Quanto caratterizzano la mia vita questi doni?
e) Sono portatore di gioia e di pace per gli altri?
5. Una chiave di lettura
per coloro che vogliono approfondire il contenuto.
"Non c’era posto per loro"
Gesù nasce in estrema povertà. Non si tratta solo dell’indigenza materiale della sua famiglia. C’è molto di più. Nasce lontano dal villaggio dove risiedono i suoi genitori, lontano dall’affetto dei famigliari e amici, lontano dalla comodità che poteva offrire la casa paterna, anche se povera. Nasce tra stranieri che non si curano di lui e non gli offrono che una mangiatoia dove nascere.
C’è qui il grande mistero dell’incarnazione. Paolo dirà che "da ricco che era, (Gesù) si è fatto povero per voi, perché diventaste ricchi per mezzo della sua povertà" (2 Cor 8, 9). Il prologo del vangelo di Giovanni attesta che pur essendo colui per mezzo del quale il mondo fu fatto, Gesù, il Verbo fatto carne, "venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto" (Gv 1,11). È questo il dramma che segna tutta la vita di Gesù raggiungendo il suo culmine nel rifiuto assoluto di lui nel processo davanti a Pilato (vedi Gv 18, 28-19, 16). È in ultima analisi il dramma di Dio che si rivela e si offre continuamente all’umanità e viene tante volte rifiutato.
Un segno da decifrare
"Non c’era posto per loro"
Gesù nasce in estrema povertà. Non si tratta solo dell’indigenza materiale della sua famiglia. C’è molto di più. Nasce lontano dal villaggio dove risiedono i suoi genitori, lontano dall’affetto dei famigliari e amici, lontano dalla comodità che poteva offrire la casa paterna, anche se povera. Nasce tra stranieri che non si curano di lui e non gli offrono che una mangiatoia dove nascere.
C’è qui il grande mistero dell’incarnazione. Paolo dirà che "da ricco che era, (Gesù) si è fatto povero per voi, perché diventaste ricchi per mezzo della sua povertà" (2 Cor 8, 9). Il prologo del vangelo di Giovanni attesta che pur essendo colui per mezzo del quale il mondo fu fatto, Gesù, il Verbo fatto carne, "venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto" (Gv 1,11). È questo il dramma che segna tutta la vita di Gesù raggiungendo il suo culmine nel rifiuto assoluto di lui nel processo davanti a Pilato (vedi Gv 18, 28-19, 16). È in ultima analisi il dramma di Dio che si rivela e si offre continuamente all’umanità e viene tante volte rifiutato.
Un segno da decifrare
Bisogna anche dire però che non era facile per i suoi contemporanei riconoscere Gesù. Non è mai facile per nessuno, nemmeno oggi, riconoscerlo per quello che egli è veramente. Solo una rivelazione da parte di Dio ci può svelare il suo mistero (vedi ad esempio Gv 5, 37; 6, 45). Nel racconto della sua nascita, lo scopo dell’annuncio angelico è proprio quello di rivelarne il mistero.
Il nostro testo infatti è composto da tre parti. Nei vv. 1-7 abbiamo il fatto della nascita di Gesù in un contesto ben determinato. È la nascita di un bambino come tanti altri. I vv. 8-14 ci riferiscono l’annuncio da parte di un angelo e la visione di angeli che cantano. È la rivelazione da parte di Dio (vedi v. 15) che ci fa scoprire nel "segno" di "un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia" (v. 12) "il salvatore, Cristo Signore" (v. 11). Nell’ultima parte (vv. 15-20) troviamo varie reazioni di fronte alla rivelazione del mistero. Il segno che Dio offre, quando viene accolto umilmente, segna il punto di partenza del cammino di fede verso colui che si rivela.
Come decifrare il segno e accogliere Gesù
Il nostro testo ci presenta tre reazioni di fronte al mistero di Gesù.
Ci sono innanzitutto i pastori. Essi sono caratterizzati da vari verbi di attesa/ricerca e scoperta: "vegliavano di notte facendo la guardia" (v. 8); "andiamo a vedere..." (v. 15); "andarono senz’indugio e trovarono ..." (v. 16). I pastori furono aperti alla rivelazione del mistero. L’hanno accolta con semplicità credendovi (vedi vv. 15 e 20) e sono divenuti testimoni di ciò che fu loro rivelato (vedi v. 17). Ci sono poi "quelli che udirono" ciò che i pastori riferirono riguardo a Gesù (v. 16). Essi si stupiscono, incapaci di cogliere il vero significato dell’evento compiutosi tra di loro. Infine c’è la reazione di Maria. L’evangelista vuole contrastare la sua reazione con quella di "quelli che udirono". Infatti la introduce con la frase "da parte sua" (v. 19). Come loro, Maria non ha udito l’annuncio dell’angelo e non ha visto il coro angelico, ma ha soltanto udito la testimonianza dei pastori. Eppure lei la coglie. Certo, aveva avuto un annuncio angelico indirizzato proprio a lei all’inizio di questa vicenda (1, 26-38). L’angelo le aveva parlato del figlio che doveva nascere da lei come del Figlio dell’Altissimo che doveva regnare per sempre (vedi 1, 32 e 35). Ma gli ultimi fatti, la sua nascita in quelle circostanze, poteva mettere in dubbio la sua parola.
Ora vengono questi pastori e di nuovo dicono cose grandi di suo figlio. Maria serba tutto nel suo cuore, le parole dell’angelo, le parole dei pastori, i fatti accaduti e cerca di metterle insieme per capire chi è questo figlio che Dio le ha donato, quale sia la missione di lui e come c’entra lei in tutto questo. Maria è una donna contemplativa che tiene aperti gli occhi e le orecchie per non perdere nulla. Poi, serba e medita tutto nel silenzio del suo cuore contemplativo. Vergine dell’ascolto, Maria è capace di cogliere la parola che Dio le rivolge nella quotidianità della sua vita.
Solo chi ha l’ansia di ricerca dei pastori e il cuore contemplativo di Maria sarà capace di decifrare i segni della presenza e degli interventi di Dio nella vita e di accogliere Gesù nella casa della propria esistenza.
6. Salmo 98
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza,
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa di Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.
Solo chi ha l’ansia di ricerca dei pastori e il cuore contemplativo di Maria sarà capace di decifrare i segni della presenza e degli interventi di Dio nella vita e di accogliere Gesù nella casa della propria esistenza.
6. Salmo 98
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza,
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa di Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.
Cantate inni al Signore con l’arpa,
con l’arpa e con suono melodioso;
con la tromba e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
Frema il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene,
che viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.
con l’arpa e con suono melodioso;
con la tromba e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene,
che viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.
7. Orazione finale
O Piccolo Bambino!
Mio unico tesoro,
mi abbandono ai tuoi
Capricci Divini.
Altra gioia non voglio
che quella di farti sorridere.
Imprimi in me le tue grazie e
le tue virtù infantili,
affinché nel giorno della mia nascita al Cielo,
gli angeli e i santi le riconoscono
nella tua piccola sposa.
(S. Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, preghiera n. 14)
Lectio Divina tratta dal sito ufficiale dell'Ordine dei Carmelitani: http://ocarm.org/it/lectio-divina
Storia del Natale
L'origine romana L'origine prettamente romana della celebrazione liturgica del Natale è fuori dubbio, anche se resta alquanto indeterminato il momento preciso in cui essa ebbe inizio.
Secondo Giovanni di Nicea (900 ca.) sarebbe stato papa Giulio (337-352) ad introdurre la festa in Roma in seguito a una corrispondenza con Cirillo, patriarca di Gerusalemme (Francois Combefis, Historia haeresis monophisitae, 304); Giovanni di Nicea dice questo nel tentativo di indurre la Chiesa Armena dissidente ad accettare la festa del 25 dicembre. Ma la corrispondenza è apocrifa e la notizia infondata.
Il Cronografo Romano (354), che è a un tempo un calendario civile e religioso, indica, in quanto calendario civile, il 25 dicembre come N(atale) invicti ("[giorno] natale del non vinto"), e, riportando l'elenco dei vescovi di Roma, dei quali precisa la data di morte, vi pone in testa, al 25 dicembre (VIII kalendas Ianuarii), la "nascita di Cristo a Betlemme di Giudea" (natus Christus in Betleem Judeae). Tale elenco sarebbe già composto nel 336, per cui la celebrazione del Natale si collocherebbe interno a questa data. Non è dato saper quale fosse il carattere di questa prima commemorazione natalizia; si pensa potesse "essere una Memoria, privilegiata senza dubbio, ma non dissimile dalle consuete Memoriae martyrum celebrate nei loro anniversari; la festa restò sempre ancorata fra quelle del santorale".
Il Cronografo Romano (354), che è a un tempo un calendario civile e religioso, indica, in quanto calendario civile, il 25 dicembre come N(atale) invicti ("[giorno] natale del non vinto"), e, riportando l'elenco dei vescovi di Roma, dei quali precisa la data di morte, vi pone in testa, al 25 dicembre (VIII kalendas Ianuarii), la "nascita di Cristo a Betlemme di Giudea" (natus Christus in Betleem Judeae). Tale elenco sarebbe già composto nel 336, per cui la celebrazione del Natale si collocherebbe interno a questa data. Non è dato saper quale fosse il carattere di questa prima commemorazione natalizia; si pensa potesse "essere una Memoria, privilegiata senza dubbio, ma non dissimile dalle consuete Memoriae martyrum celebrate nei loro anniversari; la festa restò sempre ancorata fra quelle del santorale".
Non sembra che all'epoca la Chiesa di Roma conoscesse una festa analoga all'Epifania, celebrata in Oriente il 6 gennaio; sembra sicuro che una tale festa fosse celebrata nel 376. Il fatto poi che la nascita di Gesù venga citata insieme ad una lista di date destinate a commemorare anniversari di martiri in giorni precisi ed invariabili sottolinea l'aspetto storico del Natale. A differenza della Pasqua, che è festa mobile, la nascita di Cristo è celebrata fin dall'inizio in un giorno fisso nel ciclo annuale.
La diffusione La festa natalizia già stabilizzata nel 360 e dottrinalmente ricca, passò poi in Africa: ne abbiamo notizia della celebrazione in un'omelia di Ottato di Milevi degli anni 362-363 ca.
La diffusione La festa natalizia già stabilizzata nel 360 e dottrinalmente ricca, passò poi in Africa: ne abbiamo notizia della celebrazione in un'omelia di Ottato di Milevi degli anni 362-363 ca.
Agostino parla della festività del Natale come di una memoria molto particolare: per lui si tratta del ricordo di un grande momento, di una svolta importante nella storia del mondo, ma non lo chiama sacramento, mentre usa tale termine per la festa di Pasqua.
È in San Leone Magno che si trova invece il termine sacramentum applicato al Natale; Leone lo chiama "Sacramentum natalis Christi" ("Sacramento della nascita di Cristo"), e parla del "Nativitatis dominicae sacramentum" ("Sacramento della nascita del Signore"). Leone si esprime riguardo al Natale in termini che potrebbe usare ugualmente per la Pasqua, come quando lo dice "giorno scelto per il mistero (sacramentum) della restaurazione del genere umano nella grazia".
Verso la fine del IV secolo la festa passò poi a Milano.
Per l'Oriente la prima attestazione della celebrazione è del 430; la pellegrina Egeria informa però che a Gerusalemme, all'inizio del V secolo, la nascita di Gesù è celebrata ancora il 6 gennaio. Alcuni anni dopo tuttavia, durante il soggiorno di Santa Melania in quella città (421-439) era già celebrata il 25 dicembre.
Per l'Egitto occorre attendere il 432, anno del quale è conservata un'omelia sul Natale pronunciata davanti a San Cirillo d'Alessandria.
Il giorno dell'Ottava, ancora sconosciuto dal Lezionario di Würzburg, potrebbe essere stato introdotto da Bonifacio IV (608-615).
I dati sulla celebrazione a Roma
A Roma, nella prima metà del V secolo, le celebrazioni natalizie si svolgevano nella Basilica di San Pietro. Il papa celebrava l'ufficio della Vigilia seguito dalla celebrazione eucaristica, della quale San Leone Magno ci ha dato il testo. Al canto del gallo, poi, i chierici con il papa e il popolo iniziavano l'ufficio notturno della festa, seguito, come di consueto, dalla celebrazione eucaristica; per questa il Sacramentario Gelasiano ci tramanda i testi in nocte. All'ora di Terza aveva inizio la Messa della solennità, il cui formulario ci è noto dal Sacramentario di Verona.
Con papa Sisto III (432-440) e con la costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore, al cui interno si trovava una cappella che riproduceva la grotta di Betlemme, venne celebrato un altro ufficio, più semplice, seguito dalla Messa notturna, in concomitanza con le cerimonie di San Pietro. Tale celebrazione si sviluppò poi a tal punto che quelle di San Pietro vennero trasferite in questa Basilica.
Verso la fine del IV secolo la festa passò poi a Milano.
Per l'Oriente la prima attestazione della celebrazione è del 430; la pellegrina Egeria informa però che a Gerusalemme, all'inizio del V secolo, la nascita di Gesù è celebrata ancora il 6 gennaio. Alcuni anni dopo tuttavia, durante il soggiorno di Santa Melania in quella città (421-439) era già celebrata il 25 dicembre.
Per l'Egitto occorre attendere il 432, anno del quale è conservata un'omelia sul Natale pronunciata davanti a San Cirillo d'Alessandria.
Il giorno dell'Ottava, ancora sconosciuto dal Lezionario di Würzburg, potrebbe essere stato introdotto da Bonifacio IV (608-615).
I dati sulla celebrazione a Roma
A Roma, nella prima metà del V secolo, le celebrazioni natalizie si svolgevano nella Basilica di San Pietro. Il papa celebrava l'ufficio della Vigilia seguito dalla celebrazione eucaristica, della quale San Leone Magno ci ha dato il testo. Al canto del gallo, poi, i chierici con il papa e il popolo iniziavano l'ufficio notturno della festa, seguito, come di consueto, dalla celebrazione eucaristica; per questa il Sacramentario Gelasiano ci tramanda i testi in nocte. All'ora di Terza aveva inizio la Messa della solennità, il cui formulario ci è noto dal Sacramentario di Verona.
Con papa Sisto III (432-440) e con la costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore, al cui interno si trovava una cappella che riproduceva la grotta di Betlemme, venne celebrato un altro ufficio, più semplice, seguito dalla Messa notturna, in concomitanza con le cerimonie di San Pietro. Tale celebrazione si sviluppò poi a tal punto che quelle di San Pietro vennero trasferite in questa Basilica.
Verso la metà del VI secolo risulta che il papa, invece di andare a celebrare la Messa direttamente in San Pietro, si recava a Sant'Anastasia per celebrarvi una seconda Messa; il motivo della celebrazione in quella Basilica è da trovare nel fatto che il 25 dicembre è il giorno natalizio di Sant'Anastasia martire, venerata a Costantinopoli, e la celebrazione da parte del papa veniva ad essere un ossequio all'autorità imperiale. Da Sant'Anastasia il papa si recava quindi in San Pietro per celebrarvi la Messa del giorno.
I testi della liturgia romana
Nella Chiesa latina il giorno di Natale è caratterizzato da quattro formulari per la Messa: la Messa vespertina della vigilia, la Messa della notte (popolarmente chiamata "Messa di mezzanotte"), la Messa dell'aurora, la Messa del giorno.
I testi eucologici sono particolarmente ricchi; vari di essi sono tratti dal Sacramentario di Verona, altri ne hanno tratto ispirazione. Presentano una teologia dell'attualizzazione nel tempo dei misteri di Cristo; il Natale è visto come un rinnovamento pasquale.
Le letture bibliche delle Messe del Natale hanno subito uno sviluppo, testimoniato dai vari lezionari. La seguente tabella (Adrien Nocent, 1988, 181) illustra le letture presenti nei vari lezionari e Messali:
I testi della liturgia romana
Nella Chiesa latina il giorno di Natale è caratterizzato da quattro formulari per la Messa: la Messa vespertina della vigilia, la Messa della notte (popolarmente chiamata "Messa di mezzanotte"), la Messa dell'aurora, la Messa del giorno.
I testi eucologici sono particolarmente ricchi; vari di essi sono tratti dal Sacramentario di Verona, altri ne hanno tratto ispirazione. Presentano una teologia dell'attualizzazione nel tempo dei misteri di Cristo; il Natale è visto come un rinnovamento pasquale.
Le letture bibliche delle Messe del Natale hanno subito uno sviluppo, testimoniato dai vari lezionari. La seguente tabella (Adrien Nocent, 1988, 181) illustra le letture presenti nei vari lezionari e Messali:
Messa della Vigilia
Nella Messa vespertina della Vigilia l'orientamento della liturgia è già chiaramente Pasquale: in essa sono menzionate a più riprese tre tappe del disegno di Dio:
· nell'antifona d'ingresso, ispirata a Es 16,6-7, la venuta del Signore è messa in relazione con la salvezza, e questa con la sua gloria; quest'ultima ha un significato messianico e insieme escatologico: "Oggi saprete che il Signore viene a salvarci: domani vedrete la sua gloria";
· la seconda lettura (At 13,16-17.22-25) presenta Cristo, figlio di Davide, come il salvatore d'Israele, a cui San Paolo rende testimonianza;
· la prima lettura (Is 62,1-5) presenta Sion come sua sposa regale.
Anche l'orazione colletta si iscrive nella stessa linea pasquale: "[..] concedi che possiamo guardare senza timore, quando verrà come giudice, il Cristo tuo Figlio che accogliamo in festa come Redentore".
Per il brano evangelico la liturgia del Vaticano II segue la lezione tradizionale di Mt 1,18-21, che narra la nascita di Gesù come compimento della profezia di Isaia sull'Emmanuele, ma ampliandola con la genealogia di Gesù (vv. 1-17) e aggiungendo in fondo i vv. 22-25.
Nella Messa vespertina della Vigilia l'orientamento della liturgia è già chiaramente Pasquale: in essa sono menzionate a più riprese tre tappe del disegno di Dio:
· nell'antifona d'ingresso, ispirata a Es 16,6-7, la venuta del Signore è messa in relazione con la salvezza, e questa con la sua gloria; quest'ultima ha un significato messianico e insieme escatologico: "Oggi saprete che il Signore viene a salvarci: domani vedrete la sua gloria";
· la seconda lettura (At 13,16-17.22-25) presenta Cristo, figlio di Davide, come il salvatore d'Israele, a cui San Paolo rende testimonianza;
· la prima lettura (Is 62,1-5) presenta Sion come sua sposa regale.
Anche l'orazione colletta si iscrive nella stessa linea pasquale: "[..] concedi che possiamo guardare senza timore, quando verrà come giudice, il Cristo tuo Figlio che accogliamo in festa come Redentore".
Per il brano evangelico la liturgia del Vaticano II segue la lezione tradizionale di Mt 1,18-21, che narra la nascita di Gesù come compimento della profezia di Isaia sull'Emmanuele, ma ampliandola con la genealogia di Gesù (vv. 1-17) e aggiungendo in fondo i vv. 22-25.
Messa della notte
Alla Messa della notte si legge il brano evangelico di Lc 2,1-14, seguendo la tradizione: si ascolta così l'annuncio dell'angelo: nella città di Davide è nato "un salvatore, che è il Cristo Signore".
La prima lettura (Is 9,2-7) presenta "il popolo che camminava nelle tenebre" e che "vide una grande luce".
Come seconda lettura si legge Tt 2,11-14, in cui San Paolo annuncia l'apparizione della "grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini.
Alla Messa della notte si legge il brano evangelico di Lc 2,1-14, seguendo la tradizione: si ascolta così l'annuncio dell'angelo: nella città di Davide è nato "un salvatore, che è il Cristo Signore".
La prima lettura (Is 9,2-7) presenta "il popolo che camminava nelle tenebre" e che "vide una grande luce".
Come seconda lettura si legge Tt 2,11-14, in cui San Paolo annuncia l'apparizione della "grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini.
Messa dell'aurora
La prima lettura della Messa dell'aurora è tratta da Is 62,11-12: "[..] Ecco arriva il Salvatore [..]".
Si legge poi Tt 3,4-7, che usa la terminologia della manifestazione della "bontà di Dio salvatore nostro" e del suo "amore per gli uomini]]".
Il Vangelo (Lc 2,15-20) narra dei pastori che visitano Maria, Giuseppe e il Bambino.
La prima lettura della Messa dell'aurora è tratta da Is 62,11-12: "[..] Ecco arriva il Salvatore [..]".
Si legge poi Tt 3,4-7, che usa la terminologia della manifestazione della "bontà di Dio salvatore nostro" e del suo "amore per gli uomini]]".
Il Vangelo (Lc 2,15-20) narra dei pastori che visitano Maria, Giuseppe e il Bambino.
Messa del giorno
La prima lettura presenta Is 52,7-10, a cui segue Eb 1,1-6.
La lettura evangelica è il grandioso Prologo di San Giovanni (Gv 1,1-18).
I testi della liturgia ambrosiana
Le lezioni bibliche destinate alle celebrazioni festive e feriali del tempo natalizio-epifanico sono contenute Nel Libro I del Nuovo lezionario ambrosiano dal titolo il Mistero dell’incarnazione del Signore e, più precisamente, nella seconda sezione sono contenute le liturgie festive e feriali del tempo natalizio ed epifanico. La liturgia ambrosiana si uniforma a quella romana nella durata del tempo natalizio, tuttavia contiene vistose diversità nella distribuzione delle solennità in esso ricorrenti e nella scelta delle letture.
La vigilia del Natale ha una fisionomia propriamente ambrosiana di vera e propria celebrazione vigiliare vespertina e risente dell’influsso di usi liturgici propri alla Chiesa bizantina con la quale sono ben documentati i rapporti fin dall'epoca santambrosiana. Essa prevede, per la liturgia della Parola, quattro letture veterotestamentarie (Gen 15,1-7; 1Sam 1,7c-17; Is 7,10-16; Gdc 13,2-9a) con i rispettivi salmelli a cui fa seguito l’epistola (Eb 10,37-39) e il vangelo (Mt 1,18-25) della messa nella Vigilia del Natale.
A differenza del Rito Romano, il Nuovo Lezionario Ambrosiano colloca la lettura del prologo di Giovanni nella messa nella notte anziché nella messa del giorno, evidenziando, in questo modo, la tradizione liturgica ambrosiana che colloca da subito, nella sfera divina, il mistero della natività storica del Verbo fatto carne. Si legge solo dal versetto 9 al 14 (Gv 1,9-14) in cui si annuncia l'apparire nel mondo della Luce vera. Rimanda, invece, la letture di Lc 2,1-14 alla messa nel giorno.
Significato teologico
La prima lettura presenta Is 52,7-10, a cui segue Eb 1,1-6.
La lettura evangelica è il grandioso Prologo di San Giovanni (Gv 1,1-18).
I testi della liturgia ambrosiana
Le lezioni bibliche destinate alle celebrazioni festive e feriali del tempo natalizio-epifanico sono contenute Nel Libro I del Nuovo lezionario ambrosiano dal titolo il Mistero dell’incarnazione del Signore e, più precisamente, nella seconda sezione sono contenute le liturgie festive e feriali del tempo natalizio ed epifanico. La liturgia ambrosiana si uniforma a quella romana nella durata del tempo natalizio, tuttavia contiene vistose diversità nella distribuzione delle solennità in esso ricorrenti e nella scelta delle letture.
La vigilia del Natale ha una fisionomia propriamente ambrosiana di vera e propria celebrazione vigiliare vespertina e risente dell’influsso di usi liturgici propri alla Chiesa bizantina con la quale sono ben documentati i rapporti fin dall'epoca santambrosiana. Essa prevede, per la liturgia della Parola, quattro letture veterotestamentarie (Gen 15,1-7; 1Sam 1,7c-17; Is 7,10-16; Gdc 13,2-9a) con i rispettivi salmelli a cui fa seguito l’epistola (Eb 10,37-39) e il vangelo (Mt 1,18-25) della messa nella Vigilia del Natale.
A differenza del Rito Romano, il Nuovo Lezionario Ambrosiano colloca la lettura del prologo di Giovanni nella messa nella notte anziché nella messa del giorno, evidenziando, in questo modo, la tradizione liturgica ambrosiana che colloca da subito, nella sfera divina, il mistero della natività storica del Verbo fatto carne. Si legge solo dal versetto 9 al 14 (Gv 1,9-14) in cui si annuncia l'apparire nel mondo della Luce vera. Rimanda, invece, la letture di Lc 2,1-14 alla messa nel giorno.
Significato teologico
Il mistero del Natale
« Colui che è, nasce.
Colui che è incomprensibile viene compreso.
Colui che arricchisce conosce la povertà.
Colui che è pienezza diviene vuoto.
Questo mistero mi riguarda:
io ebbi parte all'immagine di Dio
però non la conservai.
Egli allora prende parte alla mia carne
Per salvare l'immagine
E rendere immortale la carne. »
(San Gregorio Nazianzeno, Omelia 38)
Il Natale, come la Pasqua, rende presente il passaggio del cristiano dalla morte alla vita con Cristo. Si può affermare che l'oggetto della festività natalizia è il mistero della redenzione, che ha nella Pasqua il suo momento culminante. Nel Natale si tratta solo del punto di partenza dell'opera della salvezza ordinata al riscatto dell'uomo, riscatto che nell'evento del Natale è già contenuta in germe: Dio nella nascita di suo Figlio ha "dato mirabile principio alla nostra redenzione". La verità della redenzione dipende dalla verità dell'incarnazione. Il Natale è in qualche modo una Pasqua anticipata.
Le preghiere, le letture bibliche e gli altri testi dell'attuale liturgia natalizia del Messale Romano e della Liturgia delle Ore sottolineano questa dimensione salvifica del Natale.
Il cambio di prospettiva introdotto dal presepe
La tradizione del presepe, iniziata da San Francesco d'Assisi che ne allestì uno vivente a Greccio nel 1223, si diffuse subito ovunque. A livello di teologia liturgica è però da osservare che, se il presepe è tale da far comprendere in modo immediato la realtà della natura umana di Cristo, con l'accento sulla sua povertà e sul suo abbassamento nella natura umana, distorce però alquanto il significato pasquale del Natale, festa della vittoria del Cristo-Sole sulle tenebre.
Aspetti popolari odierni
In Occidente si festeggia oggi il Natale con lo scambio di doni, riunendosi per mangiare insieme, soprattutto la famiglia riunita, e spesso invitando persone non della famiglia, specialmente persone disagiate.
Nella case si prepara il presepe e si addobba l'albero di Natale.
Nei paesi prevalentemente cristiani, il Natale è diventata la festa "economicamente" più importante dell'anno; è anche celebrata come vacanza non religiosa in molti Paesi con piccole comunità cristiane. (Notizie tratte da Cathopedia - l'Enciclopedia Cattolica)
La tradizione del presepe, iniziata da San Francesco d'Assisi che ne allestì uno vivente a Greccio nel 1223, si diffuse subito ovunque. A livello di teologia liturgica è però da osservare che, se il presepe è tale da far comprendere in modo immediato la realtà della natura umana di Cristo, con l'accento sulla sua povertà e sul suo abbassamento nella natura umana, distorce però alquanto il significato pasquale del Natale, festa della vittoria del Cristo-Sole sulle tenebre.
Aspetti popolari odierni
In Occidente si festeggia oggi il Natale con lo scambio di doni, riunendosi per mangiare insieme, soprattutto la famiglia riunita, e spesso invitando persone non della famiglia, specialmente persone disagiate.
Nella case si prepara il presepe e si addobba l'albero di Natale.
Nei paesi prevalentemente cristiani, il Natale è diventata la festa "economicamente" più importante dell'anno; è anche celebrata come vacanza non religiosa in molti Paesi con piccole comunità cristiane. (Notizie tratte da Cathopedia - l'Enciclopedia Cattolica)
Le immagini dei francobolli, Area Italiana, sono tratte dal sito web: http://www.ibolli.it
mentre quelle dei francobolli Europei e Mondiali sono tratte dal sito web: http://colnect.com/it/stamps































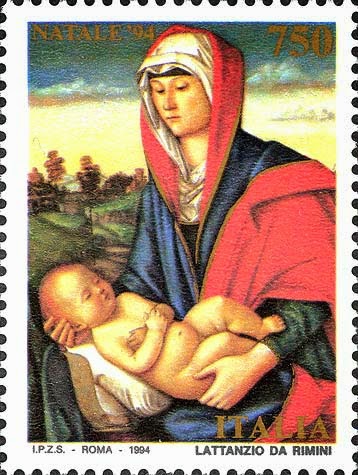









Nessun commento:
Posta un commento